Peste la colga: Roma e le epidemie
Questi giorni di “coprifuoco” generati dal diffondersi del Coronavirus, per noi abitanti del XXI secolo, cullati da decenni di fiducia nella tecnologia e nella scienza, capace sempre di proteggerci e di dominare la natura, hanno avuto l’effetto di uno shock, di una novità spiazzante e del tutto inattesa, alla quale stiamo cercando con fatica di adeguarci, nel tentativo più o meno riuscito di non farci sopraffare dal panico.
Ben diverso è il discorso se si guarda tutto dall’alto della lunga storia della nostra “città eterna”. Roma, fin dalla sua nascita, ha acquisito nei secoli una “solidissima esperienza” in materia di epidemie, uscendone sempre “vincitrice”. Nei suoi quasi 3.000 anni di vita, la nostra città è infatti sopravvissuta a dozzine di pestilenze, di virus più o meno sconosciuti, più o meno distruttivi: dal terribile vaiolo dei tempi di Marco Aurelio, alla peste seicentesca, fino al colera, narrato anche dal Belli, o all’Influenza Spagnola del 1918.
Quali soluzioni trovarono i nostri antenati per contenere i danni di quelle pandemie? Quali insegnamenti si possono trarre oggi da quelle lontane vicende? Quanto incisero sulla storia e sullo sviluppo della nostra città? Per provare a dare una risposta a queste domande e per scoprire come, ogni volta, Roma sia riuscita a ripartire, raccontiamo quanto accadde durante le epidemie che hanno attraversato e spesso sconvolto l’Urbe; vicende che hanno investito le vite di intere generazioni.

165-190 D.C.: LA PESTE ANTONINA
Anche se le cronache e le leggende parlano di grandi pestilenze fin dai primi secoli dalla nascita di Roma (la più nota intorno al 291 a.C., quando la città venne colpita da un’epidemia per contrastare la quale venne creato sull’Isola Tiberina un tempio dedicato ad Esculapio, dio della medicina), la prima di cui si abbiano fonti storiche certe, è la cosiddetta Peste Antonina, scoppiata nel 165 dopo Cristo, proprio nel periodo di massimo sviluppo dell’impero romano.
Il nome “peste” non tragga in inganno. In latino la parola pestis è infatti sinonimo di distruzione, di rovina, di epidemia appunto e veniva attribuito a ogni tipo di pandemia o pestilenza. Galeno di Pergamo, il famoso medico, ne descrisse i sintomi, parlando di un morbo che provocava febbre, diarrea, infiammazione della faringe, eruzioni cutanee secche o in forma di pustole. L’epidemia del 165 non venne quindi causata dalla peste bubbonica, che ha sintomi diversi, ma si ritiene che fu provocata dal vaiolo (o forse dal morbillo), che colpì improvvisamente Roma e tutti i territori imperiali, importata dalle truppe di ritorno nell’impero dopo la guerra contro i Parti (gli abitanti dei territori dell’attuale Armenia, Iran e Iraq).
Già il primo diffondersi della malattia provocò un altissimo numero di morti, fra cui vittime molto illustri, a partire dallo stesso imperatore Lucio Vero, che probabilmente la contrasse nel 169. Fu così che le sorti di Roma caddero interamente sulle spalle di Marco Aurelio, membro della famiglia Antonina (da cui il nome di “Peste Antonina”).
Finita la prima ondata, un secondo focolaio scoppiò a nove anni di distanza dal primo, risultando ben più virulento del precedente. In base ad alcune fonti, durante la seconda epidemia, si giunse a toccare punte di 2.000 morti al giorno nella sola città di Roma. Alla fine, nei territori dell’impero, si contò un numero enorme di vittime, stimato tra i 5 e i 30 milioni, circa un quarto dell’intera popolazione imperiale. Anche la morte dello stesso Marco Aurelio, avvenuta nel 180 d.C., pare possa essere stata causata dall’epidemia.
Le fonti dell’epoca non danno conto di particolari misure sanitarie adottate per contenere la diffusione del morbo, fatta eccezione per strani riti scaramantici, frasi benauguranti incise sulle porte delle case, o altre forme di superstizione. Quel che è certo è che, finita la pestilenza, l’impero uscì piuttosto indebolito da quell’esperienza e la fase di continua espansione dei domini, che aveva caratterizzato per secoli la storia di Roma, si arrestò definitivamente.
Anche la popolazione romana cambiò in modo deciso: per far fronte alla carenza di manodopera, causata dall’improvviso calo demografico, si ricorse sempre più spesso all’importazione di intere popolazioni barbariche, rendendo in tal modo Roma una città sempre più multietnica.
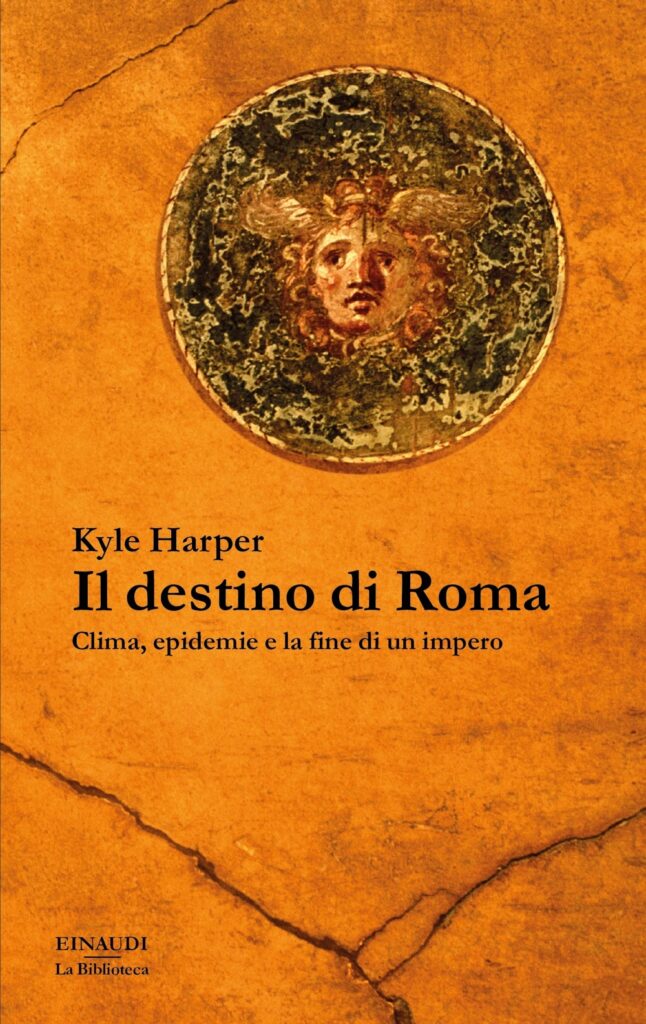
L’IMPERO ROMANO SCONFITTO DAI MORBI?
Proprio partendo dagli effetti della famigerata “Peste Antonina” del II secolo, lo storico americano Kyle Harper, in un suo recentissimo saggio intitolato Il destino di Roma (Einaudi 2019), avanza un’ipotesi inquietante e suggestiva su quanto sarebbe poi avvenuto nella nostra città. Secondo la tesi sostenuta da Harper, il crollo dell’impero romano non fu causato semplicemente dalle famigerate “invasioni barbariche” (che avrebbero avuto il solo ruolo di dare il colpo di grazia a un organismo già moribondo), ma fu preparato proprio dalle ripetute epidemie e dagli sconvolgimenti climatici che caratterizzarono il periodo che va dal secondo al sesto secolo dopo Cristo: “Il destino di Roma fu portato a compimento da imperatori e barbari, senatori e generali, soldati e schiavi, ma venne parimenti deciso da batteri e virus, eruzioni vulcaniche e cicli solari”, scrive lo studioso.
Sulla base di indagini climatologiche e chimiche, operate anche sulle ossa e gli scheletri rinvenuti dagli archeologi, Harper ipotizza che, a partire dal 150 d.C., il clima, che per secoli era stato caldo e temperato, subì un progressivo irrigidimento, mentre nuovi e fino ad allora sconosciuti batteri e virus portarono devastanti pestilenze a Roma e nell’impero (dalla cosiddetta “peste di Cipriano” del terzo secolo, a quella che scoppiò sotto il regno di Giustiniano), pandemie che indebolirono progressivamente la tenuta economica dell’impero e ne decimarono la popolazione, fino al suo definitivo collasso sotto i colpi di Goti e Vandali.

LA PESTE DEL 1656
Durante tutto il Medio Evo, Roma fu attraversata assai meno di altre località dalle grandi epidemie che funestarono l’Italia e l’intera Europa. La nostra città, però, non fu altrettanto fortunata nel 1656, allo scoppio di una nuova pestilenza che ebbe nella città di Napoli il suo principale focolaio.
Ai primi di giugno di quell’anno, infatti, un marinaio napoletano venne a soggiornare in una locanda situata in via di Monte Fiore, nel cuore di Trastevere. Il 9 giugno, il marinaio cominciò ad avvertire i primi sintomi di un forte malessere e venne ricoverato all’ospedale di San Giovanni. Purtroppo i medici non compresero subito di cosa fosse affetto, non diedero nessuna allerta e non chiesero di mettere in quarantena la locanda in cui aveva soggiornato. Fu solo il 14 giugno, quando la locandiera trasteverina e tutti i suoi figli morirono improvvisamente, che cominciò a circolare il terribile sospetto dell’arrivo a Roma della peste.
Per cercare di correre ai ripari, il 19 giugno si istituì sull’isola Tiberina, presso l’attuale ospedale Fatebenefratelli, un lazzaretto in cui mettere in quarantena tutti gli appestati dal morbo. Anche se erano trascorsi appena dieci giorni dal ricovero di quello che oggi chiameremmo il paziente zero era già tardi. Il morbo si era propagato in tutta l’area di Trastevere e anche all’interno del Ghetto ebraico. Le misure che si decise a quel punto di adottare, furono decisamente drastiche. Il Ghetto fu immediatamente sprangato, senza dar modo a nessuno di muoversi da lì, mentre tutto intorno a Trastevere fu realizzata una grande palizzata in legno, presidiata da guardie che avevano l’ordine di sparare a vista a chiunque avesse tentato di uscire. In quelle aree si impose anche un rigido divieto di riunione e il divieto di svolgere funzioni religiose pubbliche nelle chiese e nelle sinagoghe.
La pestilenza durò in tutto nove mesi, alla fine dei quali il computo dei morti in città fu di oltre 15mila, di cui 1.600 di religione ebraica, su una popolazione che all’epoca contava in tutto meno di 100mila abitanti.

1837: L’EPIDEMIA DI COLERA
È già a partire dagli anni venti e per tutti gli anni trenta dell’Ottocento che, in varie parti d’Italia e d’Europa, scoppiano grossi focolai di colera. La città di Roma e l’intero Stato Pontificio ne sembrano però totalmente immuni, al punto che persino il poeta Giuseppe Gioacchino Belli decide di farsi beffe di chi in città teme l’arrivo di questo morbo, così scrivendo in un sonetto del 1835:
Bbasta, o sse chiami còllera o ccollèra,
io sce ggiuco la testa s’un baiocco
che sta pidemeria sarvo me tocco,
cqua da noi nun ce viè, sippuro è vvera.
Nun zentite l’editto? che cchi spera
ne la Madon de mezz’agosto è un sciocco
si nn’ha ppavura? E cce vò ddunque un gnocco,
sor Marchionne, a accorasse in sta maggnera.
Disce: ma a Nninza fa ppiazza pulita.
Seggno che cqueli matti mmaledetti
nun ze sanno avé ccura de la vita.
S’invesce de cordoni e llazzaretti
se sfrustassino er culo ar Caravita,
poteríano bbruscià ppuro li letti.
Ma nel 1836 il morbo ha ormai contagiato tutto il nord Italia. Il Papa, per impedirne l’arrivo anche sul suolo pontificio, predispone allora alcune rigide contromisure e istituisce un cordone sanitario, con un apposito corpo di “Guardia Sanitaria” schierato lungo i principali snodi di confine. Nel gennaio del 1837, sempre per prevenire un’eventuale diffusione del colera, nella capitale e nel territorio pontificio vengono anche proibiti i festeggiamenti per il Carnevale. Il tentativo di contenimento, però, non ha successo e il colera inizia a diffondersi prima in Emilia, poi nelle Marche, fino ad arrivare a Roma.
Il 10 luglio del 1837 in città muore il primo contagiato. Il 24 luglio, all’ospedale San Giacomo, è la volta di una donna. Il 29 luglio muoiono due soldati nell’ospedale di Ripetta, che viene isolato. E ancora, tra il primo e il 4 agosto, si contano altri dodici morti. L’epidemia a quel punto esplode in città, agevolata anche dalla scarsa igiene generale, dalle debolezze dell’organizzazione sanitaria e dall’arretratezza delle conoscenze mediche.
Tra i metodi di “cura” più spesso prescritti, vi era infatti la somministrazione dell’oppio e dell’ossido di zinco, oltre al salasso con le sanguisughe. Metodi inefficaci, se non addirittura controproducenti.
Sarà un crescendo di mortalità fino al 10 settembre 1837, poi inizierà una fase calante, con la dichiarazione ufficiale della fine dell’epidemia il 3 novembre. Alla fine si conteranno circa 7.000 morti nella sola città di Roma.
Nuovi focolai di colera si riproporranno ancora ciclicamente per tutto l’arco dell’Ottocento, con cadenza quasi decennale, già a partire dal 1848 e fino alla fine del secolo, ma fortunatamente, nella nostra città, a differenza di quel famigerato 1837, negli anni successivi l’epidemia sarà un po’ meno virulenta, anche se quella del 1854 farà contare comunque quasi un migliaio di vittime.

1918: L’INFLUENZA SPAGNOLA
E’ un mondo ancora in guerra quello in cui, nel 1918, fa la sua comparsa l’epidemia che passerà alla storia come Influenza Spagnola, un morbo che in realtà di iberico ha ben poco, essendo originario degli Stati Uniti (ma sull’origine si nutrono ancora diversi dubbi). La Spagna, però, è all’epoca un paese neutrale, unico grande paese europeo che non partecipa al primo conflitto mondiale, e quindi sono proprio i giornali spagnoli i primi a dare la notizia dell’epidemia, non essendo sottoposti alla rigidissima censura degli stati belligeranti. Per questo si diffonde presto la falsa impressione che il contagio abbia colpito principalmente la Spagna e quell’antica fake news genera così un nome, quello di “Influenza Spagnola”, a tutt’oggi in uso.
Proprio a causa del periodo di guerra e della rigida censura a cui è sottoposta in quel momento l’informazione, ancora adesso non è possibile avere dati certi sul numero di malati e di morti. Si ritiene che forse sia stato infettato un terzo della popolazione mondiale e che più di 20 milioni di persone ne siano morte (di cui circa 500mila in Italia), ma sono stime molto approssimative.
Anche Roma rimane colpita, ma le statistiche ufficiali sui morti capitolini sono decisamente dubbie. Anzi, proprio il suo ruolo di capitale d’Italia fa passare sotto un rigido silenzio tutte le notizie relative al morbo nella nostra città, al fine di non abbassare il morale della nazione durante gli ultimi e determinanti mesi della Grande Guerra.
Nonostante la medicina abbia già fatto dei passi da gigante rispetto all’Ottocento, quella della spagnola, per numero di decessi, risulterà una delle più terribili pandemie della storia, seconda per proporzioni solo alla peste nera medievale, che falcidiò metà della popolazione europea. I sintomi sono quelli di una normale influenza: tosse, dolori muscolari, febbre, seguiti però da complicazioni polmonari che spesso portano gli ammalati a soffocare nel sangue e a morire nel giro di pochissimo tempo.
Tra le poche notizie sul morbo pubblicate all’epoca sui giornali italiani, alcune (nei nostri tempi di Coronavirus) ci appaiono piuttosto familiari. Il Corriere della Sera, ad esempio, parla di una malattia che si trasmette “mediante le particelle di muco che vengono emesse coll’aria di espirazione durante il parlare e il tossire” e raccomanda perciò di cautelarsi per mezzo di “una maschera di garza o qualche altro consimile mezzo di protezione” oltre che evitando “gli affollamenti in genere e i contatti dei sani coi malati”.
Quello che invece ci suona meno familiare è che la malattia colpisca soprattutto una fascia giovane della popolazione, quella tra i 18 e i 30 anni, risparmiando i più vecchi. Non risparmia invece personalità di spicco della cultura: da Guillaume Apollinaire a Max Weber, da Egon Schiele a Edmond Rostand, molte celebrità dell’epoca vengono portate via dal morbo.
La spagnola finisce per essere estremamente letale anche per via della povertà diffusa durante il periodo bellico, oltre che per l’assenza di antibiotici (il mondo dei primi del novecento ancora non conosce la penicillina) e per il fatto che nessuno riesca a stabilire con certezza le cause della diffusione della pandemia. Per questo, spesso, le terapie proposte per combatterla risultano fantasiose: c’è chi torna all’antico metodo dei salassi, chi inventa intrugli e strane zuppe, chi usa il chinino o l’olio di ricino, che però, essendo un lassativo, rischia di peggiorare la situazione.
A proposito di olio di ricino, c’è chi dice che anche la nascita e la diffusione fra i fascisti del saluto romano, oltre che merito della fantasia di Gabriele D’Annunzio (che per primo ne farà largo uso durante l’impresa di Fiume), sia anche una conseguenza proprio dell’epidemia di spagnola, che genera in Italia una paura diffusa per i contatti fisici, a partire dalla stretta di mano, ritenuta poco igienica e potenziale mezzo di trasmissione del virus.
Nel giro di pochi mesi, la spagnola, così come era accaduto per altre pandemie, finirà però per diminuire la sua forza. Già all’inizio del 1919 il male sembra ormai contenuto, per sparire definitivamente nel corso del 1920. Rimarrà, come dopo ogni epidemia, il dubbio sulle sue reali cause e un dibattito (ancora aperto a distanza di cento anni) fra diverse scuole di pensiero sull’efficacia o inefficacia di alcune cure e sulle misure di contenimento adottate.
I virus o i batteri, oggi come cento o come mille anni fa, continueranno sempre a sorprenderci e a spaventarci, con la loro capacità di mutazione, di diffusione repentina e inattesa; nemici invisibili e subdoli di cui è difficile comprendere le dinamiche e per questo ancor più inquietanti. Resta però il fatto che, oggi esattamente come ieri, prima o poi anche il più terribile dei virus perderà di virulenza (accadrà anche per Covid-19, di questo possiamo essere certi) e a quel punto Roma, il mondo, la storia, riprenderanno il loro corso, come se nulla fosse accaduto, con le meraviglie e gli orrori di sempre, dimenticando la paura.



Salve, e grazie, per il prezioso e interessante contributo alla conoscenza.
Buone cose
Maurizio Militello