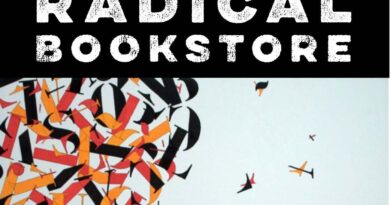Crash Kid e quella Roma cresciuta col rap
Successe tra il 1979 e il 1980. Alle feste ballavamo Good Times degli Chic, e dopo un po’ di mesi, con lo stesso ritmo, cominciammo a ballare Rapper’s Delight degli Sugarhill Gang, che usava la stessa base. Fu così, con quel pezzo rap che fu il primo a scalare le classifiche americane, che l’hip hop entrò nella nostra cultura, nel quotidiano mio e di tanti altri ragazzetti.
Crash Kid a quell’epoca aveva 9-10 anni, e quel soprannome ancora non glielo avevano affibbiato. Si chiamava Massimiliano Colonna, abitava al Portuense, come me era figlio di un lavoratore della Stefer (che a quell’epoca si chiamava già Acotral). Ma la passione per l’hip hop, in particolare per la break dance e i graffiti, lo avrebbe colto poco dopo.
Parlo di Massimiliano, detto Massimo, come se lo avessi conosciuto. No. Sono sicuro di averlo visto esibirsi per strada, impegnato a fare lo spin – la rotazione con il corpo a terra, tipica della break dance – di averlo incrociato a Ostia con amici, persone che conosco da una vita, come Ice One, di aver visto la sua tag, ma no, non l’ho mai conosciuto di persona, solo di nome.
Crash Kid è morto 22 anni fa, nel novembre 1997, ma è come se non fosse mai scomparso. Non per i suoi amici, che alcuni giorni fa lo hanno ricordato a Trastevere per la presentazione di un libro e di una mostra su di lui. Non per la scena hip hop romana e italiana, che sentono ancora la sua eredità.

Dicevamo Ice One, al secolo Sebastiano Ruocco, Seby per gli amici. È con lui, nella sua crew, che Massimo muove i primi passi, nei primi anni Ottanta. Ice One è più grande di cinque anni, un fratello maggiore. La madre di Seby è una critica d’arte, ed è anche grazie a lei che scopre una serie di artisti di avanguardia, graffitisti, già nel 1979, come Lee Quinones e Fab 5 Freddy. Poi c’è la musica. Me lo ricordo, al liceo, lui in sezione E, con la tuta Adidas, quasi una divisa d’ordinanza dei B-boy, i baffetti appena accennati. Poi diventerà dj, produttore, etc. C’è una schiera di artisti lunga così con cui Ice One ha collaborato.
Nei primissimi anni Ottanta il rap Usa smette di essere una roba per pochi, diventa popolare, non solo tra noi ragazzi di periferia, che ci immaginiamo in una specie di Bronx italico, con Roma come New York (eravamo ancora sotto l’effetto di “I guerriere della Notte”), ma anche tra il pubblico più vasto.
Succede anche grazie a film come Beat Street – che ha una fantastica colonna sonora – e soprattutto Breakin’. Ma già Flashdance, un anno prima, nel 1983, aveva sdoganato la breakdance al cinema. Succede con album come Rapped Uptight, un’antologia che contiene pezzi dei già citati Sugarhill Gang o di Grandmaster Flash – da non confondere con Grandmaster Melle Mel – ma anche di altri artisti per niente noti, da noi.
Io arrivo al rap attraverso il punk e il reggae, come per altri per me questo tipo di musica ha un valore anche politico. Non a caso, c’è tutto un filone del rap italiano che si svilupperà nei centri sociali, che darà vita più tardi a gruppi come Isola nel Kantiere o Assalti Frontali. Ho sempre amato Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa e un sacco di altri, ma per me, la band di riferimento diventa a un certo punto (e resterà) quella dei Beastie Boys, ragazzi – miei coetanei – che hanno iniziato a New York col punk (si sono conosciuti al concerto dei Black Flag). Per i puristi quello probabilmente non è rap, bensì crossover, ma non è questo il punto.
Il punto è che il movimento hip hop, visto anche con fastidio all’inizio – il rap verrà accusato di essere estraneo alla nostra tradizione melodica, i graffiti di non essere arte, la break di non essere danza, etc – si diffonde attraverso tanti canali diversi. E bisogna dare atto a Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, di essere stato davvero il suo profeta in Italia. Anche se i suoi testi erano banali e retorici, la musica commerciale, lui aveva quell’accento quasi milanese insopportabile, è soprattutto grazie a Jovanotti se il rap ha cominciato a diffondersi tra le radio e in tv, e quindi ad arrivare a tutti.
Ed è anche con la vicinanza a Jovanotti, con le comparse in tv, che Crash Kid si è affermato.

Poi c’è il capitolo dei graffiti. Che sono lontani parenti dei murales, ma non sono la stessa cosa. Eravamo abituati alle scritte e anche a immagini disegnate – quasi sempre in un contesto politico – sui muri, ma non all’uso di bus e metro come superfici artistiche. Quella, per i nostri genitori, non era arte, era vandalismo. Ma quando a inizio anni Ottanta arrivò a Palazzo delle Esposizioni – se non erro – una mostra sui graffiti, con tanto di gigantografie di vagoni della metro trasformati dai colori spray in opere d’arte mobili, con le opere di Keith Haring, era evidente che la trasformazione era in atto.
Un sacco di gente che conoscevo acquistò bombolette e iniziò a provarci (compreso mio fratello, che accompagnai una notte lungo i binari della Roma-Lido per tracciare la sua scritta, dedicata a un’amica, su un muro: non era male, con le lettere in stile fragola, rosse coi puntini neri). La maggior parte erano schifezze, d’accordo. Le tag sembravano – sembrano – più spesso un tentativo di marcare il territorio, come i cani che pisciano. Ma era qualcosa che nasceva, e che continua anche oggi: Andrea, figlio di una delle mie migliori amiche, si è portato le bombolette anche a Trento, dove ha appena iniziato l’università.

Le foto del bel libro curato dai vecchi amici di Massimo, Napal (Marcello Saolini) e Ben Matundu, Crash Kid – A Hip Hop Legacy raccontano tutti questi aspetti. Ci sono le mosse (moves) di Massimo che balla in qualsiasi tipo di posto, dalla camera di casa alla banchina della stazione Ostiense, passando per i marciapiedi. Ci sono i graffiti, con la foto della crew attorno al vagone della metro (e per il figlio di lavoratori Stefer quella non era profanazione, ma venerazione). Ci sono le star, come Afrika Bambaataa, come Jam Master Jay, ma anche Jovanotti e Pippo Baudo. Ci sono gli amici che descrivono Crash Kid, la sua arte, il loro rapporto.
Ci sono gli anni Ottanta e poi i Novanta, in cui Massimo continua a danzare, a girare il mondo, a incontrare altri B-boy. Nel frattempo l’hip hop, dopo una prima crisi, è diventato un fenomeno commerciale importante. Tutti suonano pezzi con dentro qualche rima rappata. Si è affermato il gangsta-rap, abbiamo scoperto il rap della West Coast (tipo Nwa, quelli di Fuck The Police, o Cypress Hill, il cui cantante B-Real, ha più che ispirato il modo di cantare di Caparezza…), è scoppiato il rap francese (la Francia diventa a un certo punto il secondo mercato mondiale per la musica hip hop), c’è già la nostalgia per l’old school (il rap come si faceva una volta, insomma…), viene ucciso Tupac Shakur. Io intanto ho quasi perso interesse per il genere, forse un po’ per snobismo, e mi sono orientato verso l’electro e altri suoni.
Ma c’è ancora tanta energia nell’hip hop. Lo vedo nei ragazzi che stanno in scena oggi, quelli come Salmo, ma ne potrei citare tanti altri, quelli che ascoltano i miei figli, anche cose trap, che fa orrore ai miei coetanei ma che per il mio amico Flavio è il nuovo punk.
[Le foto sono tratte dalla breve mostra a Palazzo Velli per l’uscita del Libro Crash Kid – A Hip Hop Legacy]